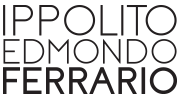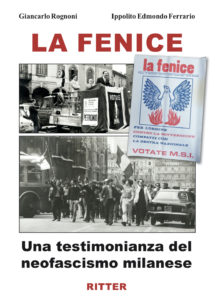da Ippolito Edmondo Ferrario | Dic 23, 2020 | News, Soldati di Ventura
“Noi fratelli d’armi in Africa come pirati”: un libro di Ferrario racconta lo spirito dei mercenari
di Matteo Brunetti, Secolo d’Italia, 20 dicembre 2020
È dal 2009 che Ippolito Edmondo Ferrario, scrittore milanese nato nel ’76, dedica parte delle sue ricerche e della sua creatività alla ricostruzione dell’epopea dei volontari italiani che hanno combattuto in Africa negli anni Sessanta. Giovani, non conformisti, coraggiosi: in molti lasciarono la famiglia, gli affetti e il benessere degli anni del boom per raggiungere il Congo. Erano militari di ventura, professionisti della guerra, che seguendo i loro ideali si ritrovarono a combattere in un paese straniero dilaniato al suo interno da un terribile conflitto armato.
Non erano soldati sanguinari
Per la loro condizione di “soldati di ventura” l’opinione pubblica e il conformismo progressista li ha sempre marchiati con l’appellativo di “les affreux”, ovvero gli orrendi, i terribili, e le loro coraggiose e disinteressate azioni, seppur volte a salvaguardare la vita della popolazione civile, passarono in secondo piano rispetto all’ingiusta fama di soldati sanguinari, fascistoidi e senza scrupoli.
La canzone di Pino Caruso al Bagaglino
“Son morto nel Katanga / venivo da Lucera…” cantava, parlandone al positivo, solo Pino Caruso in un disco inciso nel 1968 dal Bagaglino con parole di Pier Francesco Pingitore, il quale nel suo cabaret aveva avuto modo di conoscere qualche ragazzo reduce da quell’esperienza… Conformismo a parte, infatti, quella stagione è stata comunque celebrata nell’immaginario europeo e occidentale. Nei libri, nel cinema e, con la ballata di Pingitore, anche nella musica popolare. A cominciare da Africa addio, il capolavoro cinematografico di Gualtiero Jacopetti che il regista girò – insieme al suo amico e sodale Franco Prosperi – proprio seguendo i mercenari e osservando in presa diretta le loro imprese.
I film che celebrano i mercenari d’Africa
Oppure ai due film che celebrarono al meglio la figura di “quei” ragazzi in Africa: I quattro dell’Oca selvaggia del 1977 e I mastini della guerra del 1980, entrambi trasposizione cinematografica di due bei libri, il primo di Bob Carney, il secondo di Frederick Forsyth, lo scrittore britannico che dedicava il romanzo anche a Pier Giorgio Norbiato, un eroico italiano soprannominato “le fasciste”.
Il libro di Ferrario: Maktub, Congo-Yemen 1965-1969
Appunto, in tutta questa bibliografia, mancava sinora adeguatamente il ruolo svolto dagli italiani, che pure c’erano e non sono stati pochi. Ed ecco con questo ultimo Maktub. Congo-Yemen 1965-1969 (Edizioni Ritter, pp. 107, euro 24,00), Ferrario a quattro mani con Robert Müller, uno dei protagonisti di quell’epopea, manda in libreria un bellissimo libro in grande formato con tutto il racconto fotografico, passo dopo passo, tanto che il risultato è quasi cinematografico.
Le esperienze raccontate nel libro
Müller, classe ’42, figlio di un soldato della Wehrmacht e di madre italiana, nel ’65 parte alla volta del Congo Belga insieme a Girolamo Simonetti. Catapultati in una realtà cruda e spietata, fatta di massacri tribali, morte e distruzione, diventano presto “fratelli d’armi”, entrando a far parte del leggendario gruppo Paras Cobra. Nel ’68, solo qualche anno dopo, Müller raggiunge il deserto dello Yemen per combattere a fianco dei ribelli realisti sostenuti dall’Arabia Saudita contro i repubblicani filo-sovietici. Il libro curato con Ferrario rievoca e racconta entrambe le esperienze.
Centinaia di foto
Non mancano tra le centinaia di foto, quelle più goliardiche e giovanilistiche. In particolare, c’è n’è una in cui Simonetti e Müller “giocano” a fare i pirati. Commentata da parole dello stesso Simonetti, l’amico romano – forse proprio colui che parlandone al Bagaglino ispirò Pingitore – che era partito con l’Africa insieme a Müller: “Fra tutti i paragoni fatti, quello che mi sento d’accettare come più vicino allo spirito mercenario è quello con i pirati. Pirati all’arrembaggio in un mare ostile di incomprensioni, che necessita della loro presenza, ma li disprezza, in un mare di opportunismi, di accordi al vertice, di materialismo d’ogni colore, di specioso e interessato perbenismo. Pirati del XX secolo, che difendono la loro filibusta con la sciabola in una mano, mentre con l’altra ghermiscono una bottiglia di Rhum e combattono irridendo al nemico, incuranti di tutto e di tutti”.

da Ippolito Edmondo Ferrario | Dic 21, 2020 | Accadde Domani
ACCADDE DOMANI. 12 DICEMBRE 1969. GIANCARLO ROGNONI E LA STRAGE DI PIAZZA FONTANA. UNA TESTIMONIANZA INEDITA (Seconda parte)
Fu grazie a Foscari che Siciliano venne introdotto all’ambiente milanese.
Ricordo un ultimo dell’anno trascorso a casa di un camerata milanese, Franco Mojana a cui partecipai insieme a Siciliano e altri. Verso le cinque del mattino ricevetti a casa una telefonata da una comune amica, Ada.
Ricordo che la ragazza mi chiese di poter fare da testimone al matrimonio tra le e Martino che si erano conosciuti quella sera stessa…Al momento non avevo compreso, pensando al mio ruolo di testimone per un incidente accaduto magari nella notte, rientrando dalla festa, e non per le loro nozze.
Sono tutti episodi che ben poco hanno a che vedere con riunioni e organizzazioni di attentati e stragi… Successivamente, vicissitudini personali, portarono Siciliano a tentare anche il suicidio nei servizi di un bar vicino alla sede del Msi a Milano.
A tutta una serie di illazioni mossemi, risposi portando diverse prove concrete.Dimostrai la mia presenza sul posto di lavoro, in banca, il 12 dicembre grazie ad una dichiarazione della Banca Commerciale Italiana, l’istituto per cui lavoravo in una delle filiali situata in viale Campania.
Tale documento fu fondamentale perché impedì all’accusa di conferirmi il ruolo di colui che aveva addirittura posto l’ordigno all’interno dei locali in piazza Fontana; rimanevano però le accuse di aver fornito supporto logistico.
Su come poi si sarebbe svolto il mio 12 dicembre entrerò nel merito successivamente riportando un episodio in particolare.
Approntai una difesa in più punti per dimostrare la mia estraneità ai fatti, ma gli sforzi furono inutili.
Si volle sostenere un sillogismo per il quale, essendo in contatto con i supposti autori della strage, io stesso dovevo avervi preso parte secondo precise modalità logistiche.
Il 28 giugno 2001 presenzia in aula rilasciai ai giudici questa mia dichiarazione: «(…)Quest’ultimo aspetto voglio sottolinearlo perché ha una certa attinenza con questo processo che vede la tesi accusatoria reggersi in larga parte sulle vociferazioni che sarebbero corse in ambito carcerario.
È una banale ovvietà, ma voglio ribadirlo.
Il carcere è un ambiente degradante e corruttore.
Considerate che io, cinquantaseienne, le sole volte che vidi droghe di tutti i tipi fu proprio quando ero detenuto nei cosiddetti carceri speciali. In carcere è facile smarrirsi. Il dottor Maggi mi fu vicino venendomi a trovare, scrivendomi, inviandomi libri, facendomi sentire insomma parte di una comunità viva.
Per chi non dispone di simili ancore e magari non dispone di una salda struttura spirituale è facile piegarsi e spesso sprofondare nella degradazione e nell’abiezione.
Altrettando facile subire sollecitazioni e lusinghe oppure reagire agli stimoli come una sorta di riflesso pavloviano. Ed è quanto mi pare sia avvenuto per alcuni.
Ad esempio Bonazzi. Individuo un pezzo di una lettera che da poco ho ritrovato che egli mi scrisse dal carcere di Nuoro l’8/10/80, proprio nel 1980, e mi dice: “Da parte mia ho preparato un pezzo sulla strage che apparirà su un giornaletto di camerati a firma Quex”.
“È chiaro che la strage è di potere” lo scrive maiuscolo e sottolineato.
“Su questo non ci possono esserci dubbi”.
Ed ora indica come uno fra i responsabili me, che con il potere ho certo ben poco a che vedere.
Spesso, durante le udienze, è stata ventilata l’esistenza di una sorta di incitamento alla violenza da parte della Fenice. Orbene questo periodico era regolarmente registrato, tutti i numeri depositati.
Eppure nessun articolo è stato presentato a sostegno di questa tesi. Segnalo anzi che il motto campeggiante tutte le prime pagine dei vari numeri era quello di Don Bosco, “Nello sport, come nella vita, audaci, forti, leali e generosi” a cui avevamo sostituito “sport” con “impegno politico” e rappresentava, questo sì, il nostro pensiero.
Debbo dire, e credetemi che è assolutamente la verità, arrivati alla conclusione di questo processo, non ho ancora ben capito che cosa io avrei esattamente fatto, quale sarebbe stato il mio ruolo in questo progetto criminale.
Si è molto parlato dei tempi e dei luoghi in cui io ho conosciuto i miei coimputati e il Siciliano.
Mi pare che una parte civile per sostenere una tesi accusatoria mi abbia fatto presenziare negli stessi giorni a eventi differenti con differenti persone siti in luoghi a centinaia di chilometri di distanza l’uno dall’altro. Io non ho conosciuto Siciliano nell’occasione indicata dallo stesso e ho conosciuto i miei imputati solo in data susseguente a quella della strage. Essenziale però a mio giudizio non è nemmeno questo, bensì il fatto che io non ho avuto, né nella genesi né nella realizzazione di questo attentato, alcun ruolo.
Mi pare quasi che si stia presentando un paradosso assurdo. Da un punto di vista giudiziario, ovviamente non morale, sarebbe quasi preferibile che io avessi assunto un qualche ruolo, magari marginale, per poter, confessando, sfuggire, tramite prescrizione, al giudizio. In realtà però è che non posso e neppur volendo, confessare alcunché. Dovrei mentire benchè non veda che ruolo credibile potrei creare anche in considerazione del fatto che le indagini hanno permesso di appurare che il giorno della strage io ero al mio posto di lavoro.
È infatti presumibile che, in un piano così articolato e complesso, nessuno spazio possa essere affidato a complici non necessari e, nel mio caso, fonte di possibile identificazione.
Fra l’altro credo che l’intossicazione a cui fu sottoposto lo schieramento politico a cui appartengo sia frutto di tecniche di disinformazione e depistaggio attuate a posteriori.
Se la regia vi fu, questa costruzione di indizi attuata dopo i fatti, si rivela molto labile per le difficoltà di distinguere il vero dal falso, sia per il passare del tempo, che offusca i ricordi, sia per la disinformazione che fu attuata ai danni di un’area in anni di forti tensioni politiche e sociali in cui a volte varie persone si sono trovati ad essere involontari attori o comparse.
Il Pubblico Ministero, con un’immagine suggestiva, suggerisce che non credere all’impianto accusatorio equivarrebbe a considerare colpevoli di un complotto inquirenti e magistrati che hanno istruito questo procedimento.
Questo non è vero. Io ho molto apprezzato le indagini di polizia giudiaziale eseguite su disposizione della pubblica accusa tendenti a verificare le mie dichiarazioni. D’altronde non poteva essere differentemente, dato che proprio i risultati di quelle indagini costituiscono larga parte della mia difesa.
Pensavo anzi che il Pm desse maggior credito alle indagini da lui disposte.
Quello che ho molto apprezzato, durante il drammatico interrogatorio cui fu sottoposto Azzi in carcere, è che lo stesso, riaffermando l’astio nei miei confronti, ribadiva di non aver mai fatto dichiarazioni sui miei presunti coinvolgimenti nella strage di piazza Fontana. Ho apprezzato, dicevo, il comportamento della pubblica accusa che rifiutava la scorciatoia proposta dell’avvocato dell’Azzi per uscire dall’empasse e cioè il mio arresto.
Credo che il Pubblico Ministero sia convinto della tesi accusatoria da lui proposta, e non abbia chiesto la mia condanna solo per appagare la legittima soddisfazione di aver chiuso il caso.
Questo però ai miei occhi non fa di lui motore di un complotto bensì semplicemente un uomo che sbaglia, perché sbaglia. Su alcuni organi di stampa questo processo è stato presentato come l’ultima occasione.
Se debbo essere sincero questo è per me motivo di preoccupazione.
Il timore cioè che si colga questa occasione per chiudere in qualche modo il caso trovando dei colpevoli pur che sia. Nei sopravvissuti si sviluppa una forte ritrosia a rivisitare quegli anni, vuoi per un desiderio di cancellazione, vuoi perché tentati inconsciamente di attribuire a sé stessi il ruolo dei buoni, vuoi perché non vogliono coinvolgere persone con cui in un lontano passato hanno condiviso battaglie politiche che spesso portavano a scontri radicali e ciò spiega le eventuali discrepanze o reticenze.
Come ho già detto non posso che augurarmi, anche sotto l’aspetto egoistico di un tornaconto giudiziario, che i colpevoli siano trovati e che io sia giudicato per le azioni da me compiute e non per la fede politica professata, che voi possiate, seppur a distanza di tanti anni, offrire giustizia e che questa sia figlia della verità.
Per concludere questa mia dichiarazione voglio pubblicamente, con pacatezza, ma anche con forte determinazione, affermare che per questo orribile reato sono completamente innocente»,
Il primo grado si concluse per me con la condanna all’ergastolo.
Il giorno che appresi della sentenza vissi un profondo senso smarrimento.
Provai la tentazione di arrendermi, di non riconoscere la giustizia che mi stava giudicando e addirittura di non fare ricorso.
Non mi aspettavo di essere condannato all’ergastolo di fronte ad accuse totalmente inconsistenti.
La prospettiva di rimettere in gioco completamente la mia vita con un mio ritorno in carcere era cosa concreta.
Se una parte di me avrebbe voluto arrendersi, l’altra reagì.Proseguii nel dimostrare la mia innocenza.
Non mollai grazie alla mia famiglia, all’insistenza di Franca, mia moglie e del mio avvocato.
Così, con rinnovato vigore, affrontammo il secondo grado del processo, sforzandoci di smontare, dopo averle analizzate, tutte le varie tesi accusatorie. Fu un lavoro enorme, intenso che richiese uno sforzo notevole.
Trascorsi settimane facendo ricerche, acquisendo articoli e documenti nelle biblioteche, al fine di documentare meglio le date e l’inquadramento cronologico di molti fatti attinenti il processo.
Tusa mi aiutò in questo compito, mentre a difendermi ebbi anche l’avvocato Enzo Fragalà che si concentrò sugli aspetti più politici della vicenda, ma non solo.
I tempi della giustizia furono lunghi, ma alla fine fummo in grado di dimostrare la mia totale estraneità ai fatti. Appresi della mia piena assoluzione dall’estero.
Una parte di me era certa che non mi avrebbero assolto. Non avevo fiducia nella giustizia e quindi decisi che prima di tornare in carcere, se così sarebbe stato, avrei percorso ancora una volta il cammino di Santiago.
Sulla via del ritorno fui raggiunto dalla telefonata nella quale Franca mi comunicava la piena assoluzione.
Fu una vittoria, ma conquistata ad un caro prezzo perché vissi quegli anni, ben undici, con la prospettiva di non riuscire a dimostrare la mia innocenza.
Al termine di questa sofferta vicenda giudiziaria affidai un breve comunicato agli organi di stampa. Con alcune precisazioni misi la parola fine a lungo iter giudiziario.
Giancarlo Rognoni, Ippolito Edmondo Ferrario, La Fenice. Una testimonianza del neofascismo milanese, Ritter Edizioni
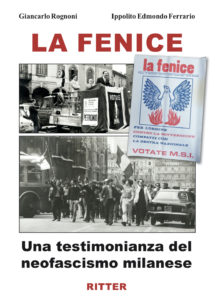

da Ippolito Edmondo Ferrario | Ott 22, 2020 | Accadde Domani
21 ottobre 1981. Un commando armato formato Alessandro Alibrandi, Francesca Mambro, Gilberto Cavallini, Giorgio Vale, Stefano Soderini, Walter Sordi uccide il capitano di P.S. Francesco Straullu e la guardia scelta Ciriaco Di Roma. Mimmo Magnetta ricorda l’incontro con il capitano Straullu che ha coordinato il suo arresto al valico del Gaggiolo
Il mio percorso carcerario, dopo l’arresto, è riassumibile nelle seguenti tappe. I primi due giorni li trascorsi a Varese in camera di sicurezza, poi ne trascorsi cinque a Roma, sempre in camera di sicurezza. Al mio arrivo a Roma c’era ad accogliermi il capitano di P.S. Francesco Straullu. So che in cambio della collaborazione Straullu aveva offerto ad altri la cifra di trecento milioni di lire e una nuova identità. Con me e con Dimitri non accennò mai a eventuali prospettive di collaborazione. Appena scesi dalla macchina che mi aveva portato dalla questura di Varese a Roma, lui volle vedermi. Io ero scortato da due poliziotti. Mi venne incontro con modi affabili chiedendomi se gli concedevo l’onore di stringergli la mano. Era un uomo giovane, non molto alto. Vestiva in borghese, indossava una maglietta polo, un golf arrotolato in vita e jeans. Dalle tasche spuntava arrotolata una copia de “Il Manifesto”. Io gli chiesi chi fosse. Lui si presentò come il capitano Straullu, colui che aveva coordinato l’operazione che aveva portato al mio arresto. Io gli risposi con un “complimenti”. Poi insistette nel volermi stringere la mano e gli chiesi il motivo.
– Tu e il tuo amico Peppe Dimitri siete gli unici della banda dei Nar che sapete perché fate certe cose. Agli altri vostri camerati bisogna dare uno schiaffo per parlare e due per farli stare zitti.
Gli diedi la mano. Era un po’ come ricevere l’onore delle armi. Lui si accorse dei segni che portavo in volto, frutto del trattamento ricevuto a Varese una volta tratto in arresto. Lo stesso procuratore di Varese, giorni prima, alla presenza dei sette operatori di polizia che mi avevano menato, mi aveva invitato a parlare e a fare i nomi degli agenti che mi avevano pestato.
– In questa stanza l’unico a non dover avere paura sono io… – risposi al procuratore.
Gli agenti erano in piedi, messi a semicerchio intorno a me. Sentivo il loro fiato sul collo. Li avevo guardati uno per uno e poi, rivolgendomi al Procuratore, avevo dichiarato, come si usava, che ero caduto dalle scale. Era evidente che non poteva essere andata così, ma, come era regola mia e degli avanguardisti, non avevo parlato. Firmata la dichiarazione venni portato fuori dalla stanza. Qui uno dei poliziotti mi disse:
– Mimmo, ti dobbiamo delle scuse. Ci devi scusare…
Io li mandai affanculo, gli dissi di riportarmi in cella e che delle loro scuse me ne fregavo.
Straullu con me fu gentile. In quei cinque giorni che rimasi in cella di sicurezza a Roma in questura, dato che fin dal primo momento dell’arresto non avevo toccato cibo, mi fece arrivare parecchie cose extra da mangiare: maritozzi con la panna, spremute d’arancia e altro. Io continuai però a non toccare cibo.
Tratto da: Domenico “Mimmo” Magnetta, Ippolito Edmondo Ferrario, Una vita in Avanguardia Nazionale, Ritter Edizioni